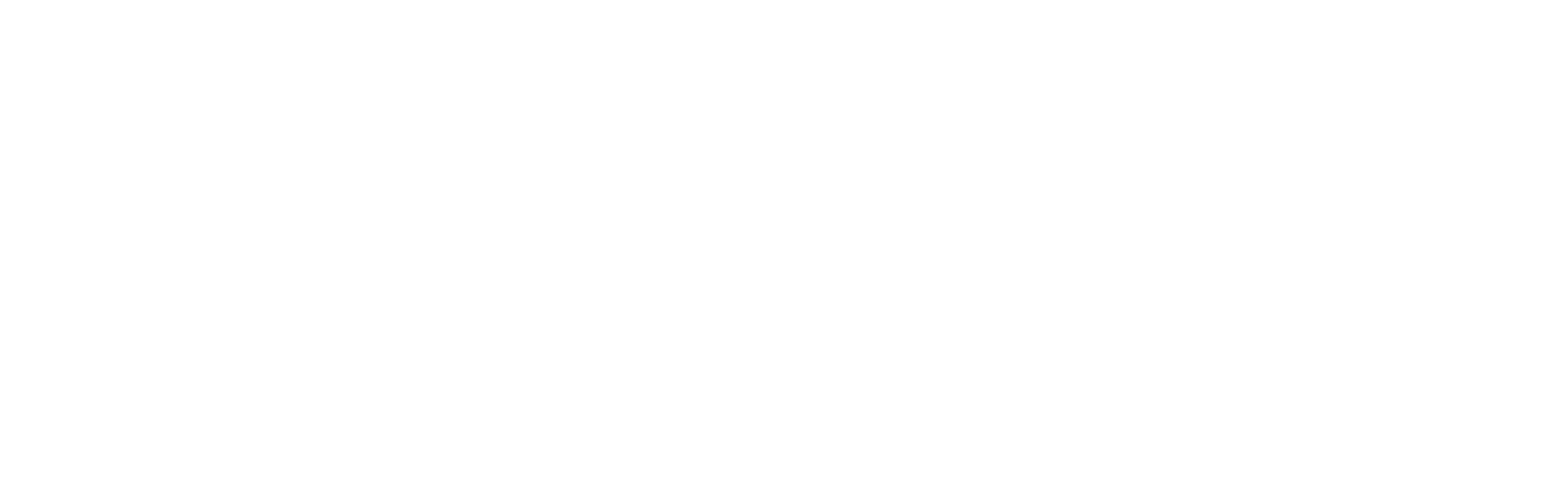Il presente parere è stato redatto dal dott. Andrea G. Tuzio su richiesta dell’Ordine e pubblicato in data 22.07.2025.
Si precisa preliminarmente che l’interpretazione delle disposizioni normative non rientra tra le attribuzioni di competenza di questo Ordine. Pertanto, il presente contributo ha carattere esclusivamente consultivo e non assume valore vincolante.
In merito al primo quesito, ovvero se in uno studio odontoiatrico il professionista titolare cedesse la propria attività ad una STP in forma di SRL unipersonale, i requisiti minimi “strutturali” sarebbero gli stessi che si applicherebbero ad una SRL commerciale, si precisa quanto segue.
Come noto, il quadro normativo di riferimento delle Regione Piemonte si compone principalmente da:
- la Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i., che individua i requisiti minimi autorizzativi in relazione alle Case di cura private;
- la DCR 22 febbraio 2000, n. 616-3149, che indica i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la DGR 22 marzo 2019, n. 31-8596, che disciplina le tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i.
Ulteriori criteri di definizione per le attività soggette al regime autorizzatorio possono essere reperiti dal disposto dell’art. 8-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. che assoggetta all’autorizzazione le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale nonché gli studi odontoiatrici, oltre che medici e di altre professioni sanitarie, “…ove si attrezzi per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”.
Per “ambulatorio” di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno. Nelle strutture sanitarie ambulatoriali non è consentito l’esercizio dell’attività senza la nomina di un Direttore Sanitario.
I presidi ambulatoriali si configurano quali imprese, ai sensi degli artt. 2082 e segg. del Codice Civile, sono quindi caratterizzati da un’imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara separazione tra una responsabilità di tipo:
- imprenditoriale (che fa capo all’amministratore della società);
- tecnico – organizzativa (che fa capo al direttore sanitario);
- professionale (che fa capo all’esecutore della prestazione).
Per “studio professionale” si intende invece la sede di espletamento dell’attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia e caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori.
L’originaria disciplina in ambito nazionale prevedeva una netta contrapposizione tra “ambulatori” e “studi medici”, assoggettando solo i primi al regime dell’autorizzazione all’esercizio. Il riordino della disciplina in materia sanitaria – D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. – ha successivamente introdotto una duplice componente che incide sull’esercizio dell’attività sanitaria: un aspetto soggettivo (il professionista esecutore delle prestazioni “di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”) e un aspetto oggettivo (la struttura ovvero lo studio in possesso di determinati requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi).
La necessità dell’obbligo autorizzativo è stata, pertanto, estesa oltre che agli ambulatori, anche agli studi professionali qualora svolgano prestazioni di “particolare complessità” o che comportino un “rischio per il paziente”.
I requisiti minimi che gli ambulatori e gli studi professionali devono rispettare, generalmente differenti per le due tipologie di attività, sono suddivisi in tre macroaree (Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997):
- requisiti strutturali (superfici minime, numero servizi igienici, eventuale abbattimento barriere architettoniche etc.);
- requisiti tecnologici-impiantistici (caratteristiche e tipologia di impianti, macchinari da utilizzare etc.);
- requisiti organizzativi (personale in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, protocolli dettagliati per la sanificazione degli ambienti e le modalità disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, etc.).
Con la riforma Costituzionale del 2001 (legge n. 3/2001) è stato modificato profondamente il Titolo V della Costituzione, che riguarda “Le Regioni, le Province e i Comuni”, riorganizzando il sistema di governo territoriale e ridefinendo i rapporti tra Stato e enti territoriali.
La riforma del 2001 ha rafforzato il ruolo delle Regioni, attribuendo loro ampie competenze legislative, e ha introdotto un sistema di potestà legislative che prevede materie di competenza esclusiva dello Stato, materie di competenza esclusiva delle Regioni e materie di competenza concorrente (tra cui la tutela della salute).
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Nella Regione Piemonte, ai sensi della Delibera Consiglio Regionale (DCR) 22 febbraio 2000, n. 616–3149, sono soggette ad autorizzazione e a specifici requisiti minimi le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regima ambulatoriale. Non sono assoggettati, invece, al regime autorizzativo gli studi professionali medici e/o odontoiatrici, per i quali non sono previsti nemmeno specifici requisiti minimi strutturali, tecnologici-impiantistici e organizzativi.
A seguito dell’introduzione delle novità legislative di cui:
- la Legge 12 Novembre 2011, n. 183 (Articolo 10);
- il Decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1, Convertito Con Legge 24 Marzo 2012, n. 27 (Articolo 9 Bis);
- il Decreto Ministeriale 8 Febbraio 2013, n. 34;
è stata introdotta la creazione di un’organizzazione societaria, la c.d. società tra professionisti (STP), il cui fine primario è l’esercizio dell’attività professionale.
La società tra professionisti non costituisce un tipo di società a sé stante: essa è disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme specificamente introdotte dalla legge in relazione al suo particolare oggetto sociale.
Le STP possono, quindi, costituirsi nelle seguenti forme:
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative.
L’aspetto distintivo da considerare è la persistenza della personalità della prestazione: l’attività professionale rimane sempre attribuibile al singolo professionista, il quale risulta contemporaneamente socio. La Società Tra Professionisti è caratterizzata dall’avere come oggetto sociale l’esercizio di una specifica professione. Per conciliare la personalità nell’esecuzione dell’incarico (articolo 2232 del Codice civile) con l’esercizio condiviso, caratteristica essenziale delle società, la legge ha così equiparato la società a un singolo professionista, richiedendo la sua iscrizione nell’albo professionale competente e conferendole il potere di accettare l’incarico. In questa situazione, i soci, che sono professionisti iscritti ad un albo, offrono i loro servizi professionali per conto della società: è la società stessa che stipula i contratti con i terzi. Gli incarichi professionali non sono presi individualmente dai singoli soci, ma dalla società, come entità autonoma. Anche se l’incarico è assunto dalla società, «la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità» per salvaguardare il principio di personalità della prestazione professionale.
Apparentemente, la S.T.P. unipersonale potrebbe sembrare un controsenso, in quanto la disciplina delle società tra professionisti nasce proprio con lo scopo di agevolare l’esercizio collettivo delle attività professionali. Viceversa, l’impiego dello strumento della società unipersonale avrebbe il solo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell’attività economica al patrimonio della società. Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di enti. Nella L. 183/2011 mancano disposizioni specifiche che impongano il carattere pluripersonale della S.T.P. e la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della S.p.A. e della s.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale. Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una S.T.P. unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta.
Pertanto, l’elemento professionalizzante in aggiunta a quello della personalità della prestazione caratterizzano in maniera peculiare la STP, consentendo di assimilare tale fattispecie a quella dello studio medico e distinguendola nettamente dall’attività di impresa (e quindi dall’ambulatorio).
Il Legislatore, infatti, nell’introdurre la forma della “società tra professionisti” ha previsto che la stessa rimanesse – sul piano giuridico – comunque saldamente ancorata all’ambito professionale: ciò che distingue la società tra professionisti dalle società commerciali è proprio la prevalenza dell’elemento oggettivo ovvero l’esercizio dell’attività professionale in via esclusiva e di conseguenza l’intuitu personae, cioè il carattere personale della prestazione.
Appare evidente, dunque, che le STP al pari degli studi professionali medici e/o odontoiatrici – nell’alveo della legislazione del Piemonte – debbano ritenersi non soggette ad autorizzazione comunale e ai requisiti minimi strutturali, tecnologici-impiantistici e organizzativi previsti per le strutture ambulatoriali.
Diversamente, non valorizzando l’elemento oggettivo dello svolgimento in via esclusiva della professione e della personalità della prestazione verrebbe meno la natura stessa della STP, che finirebbe per essere assimilata ad una società commerciale a tutti gli effetti.
Del resto, diverse Regioni come Lazio, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia – la cui menzione si intende a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – hanno già disciplinato in tal senso ovvero assoggettando le STP al medesimo regime degli studi professionali.
Si ritiene, pertanto, che nell’ambito della Regione Piemonte la STP possa operare ritenendosi esente dall’iter autorizzativo e conformandosi esclusivamente al menzionato Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 ed alle leggi vigenti in materia, nonché nel rispetto dei requisiti professionali richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività medica/odontoiatrica e degli ulteriori requisiti previsti per gli studi medici dai regolamenti comunali in materia edilizia, oltre che dalla norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
In virtù di quanto sopra illustrato, si auspica, tuttavia, quanto prima un intervento del Legislatore regionale che possa chiarificare ogni dubbio, disciplinando puntualmente il regime di operatività degli studi professionali medici e odontoiatrici e delle società tra professionisti, ad essi assimilate per natura e oggetto.