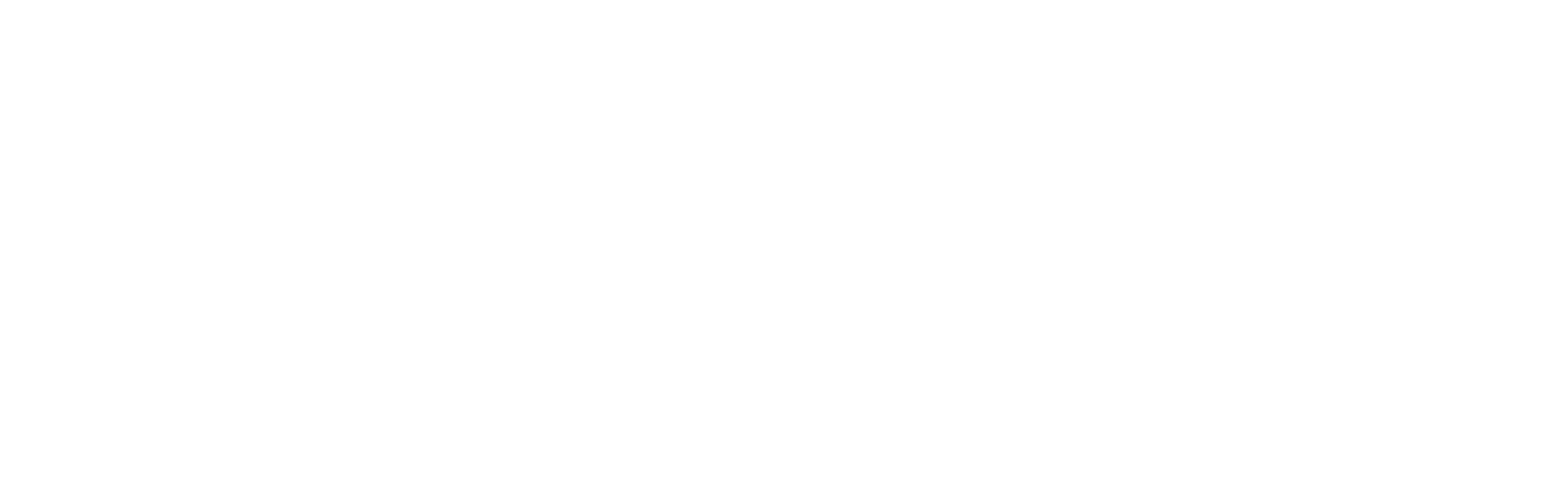I danni per la salute causati dall’inquinamento atmosferico sono ormai ampiamente noti e documentati e l’area metropolitana torinese è tra quelle più compromesse. È quindi naturale che un medico – grazie alle competenze e alla cultura metodologica tipiche della propria professione – si ponga delle domande, soprattutto su come le istituzioni locali affrontano il problema e su quali strategie possano adottare i cittadini per proteggersi. Si tratta di interrogativi espressi con umiltà, presentati come riflessioni “da strada”, ma rielaborati secondo gli schemi dell’approccio clinico. Un metodo applicabile anche all’inquinamento atmosferico, che non è solo un grave fattore di rischio, ma un vero e proprio processo patologico.
Premessa. Considerando l’inquinamento in ottica clinica si può affermare che si tratta di una patologia grave per mortalità e danni a vari livelli. È un problema urgente, che non sembra in sufficiente regressione nonostante le strategie di controllo adottate dalle istituzioni. Ne consegue che un medico si chieda innanzitutto quali siano il protocollo e l’organigramma alla base del coordinamento della rete di contrasto all’inquinamento, nonché quali competenze e figure siano coinvolte.
Cause e meccanismi. È evidente che il problema climatico ha una dimensione globale e non è risolvibile a livello locale, tuttavia ci si chiede perché, proprio rispetto alle componenti locali, i provvedimenti si concentrino quasi esclusivamente sul traffico e molto meno su altri fattori altrettanto rilevanti, come i riscaldamenti/aria condizionata e il settore agro-zootecnico, in particolare gli allevamenti intensivi, notoriamente responsabili di una quota significativa dell’inquinamento.
Elementi operativi. Sarebbe utile conoscere le premesse, gli obiettivi, il piano degli interventi e l’efficacia prevista nel tempo. In particolare, è fondamentale ribadire che il problema dell’inquinamento è urgente: ogni giorno molte persone si ammalano, muoiono o subiscono danni con ripercussioni future. Per questa ragione, l’approccio dovrebbe garantire risultati anche nel breve termine: educare i bambini a non inquinare, per esempio, è importante, ma avrà effetti solo nel lungo periodo e non serve per contrastare la crisi attuale. Altrettanto poco efficace, data l’urgenza, è la proliferazione di conferenze e convegni (utili soprattutto a gratificare gli organizzatori e i partecipanti) che ribadiscono i danni dell’inquinamento, un dato ormai noto persino ai bambini.
Terapie e bias. Intervenire sull’inquinamento richiede azioni su più livelli, sia sulle cause scatenanti (un sistema complesso, non una singola eziologia) sia sulle componenti sintomatiche. Al momento, le misure adottate si concentrano principalmente sulla riduzione del traffico automobilistico a favore di mezzi alternativi. Tuttavia non è chiaro se i provvedimenti adottati – prevalentemente incentrati sul sostegno al trasporto pubblico, sulle le piste ciclabili, sui blocchi ai veicoli più inquinanti, sulle limitazioni di velocità e su aree pedonali e a traffico limitato – siano realmente efficaci o se, in alcuni casi, non risultino addirittura controproducenti. Non è sempre detto che questi interventi siano privi di “bias”, termine che indica un pregiudizio o un’alterazione dei dati, spesso derivante da un intento ideologico o commerciale, che porta a cercare di dimostrare a priori il verificarsi di un fenomeno anziché valutarlo in modo oggettivo e senza preconcetti.
Trasponendo al traffico l’approccio statistico/auxologico, appare ragionevole pensare che l’inquinamento prodotto dalle automobili non dipenda tanto dalla velocità di ogni singolo veicolo, quanto dal numero complessivo di veicoli in circolazione, dal numero di giri del motore (marce basse) e dalla frequenza delle loro variazioni, dal numero e dall’intensità delle frenate, dal tempo di permanenza nel traffico e dai chilometri percorsi. Si tratta, quindi, di un’equazione piuttosto complessa.
Da questo punto di vista sorge il dubbio che i provvedimenti citati possano essere applicati in modo inadeguato o, paradossalmente, risultare controproducenti. Ad esempio alcune aree pedonali, zone a traffico limitato o piste ciclabili potrebbero non servire a ridurre il numero complessivo di veicoli in circolazione, ma ad aumentare la congestione, con conseguente incremento dei giri del motore, del tempo di permanenza nel traffico e delle frenate, peggiorando così l’inquinamento e finendo anche per esporre maggiormente alle emissioni proprio coloro che scelgono mezzi più sostenibili.
Ciò non significa che non sia necessario ridurre l’uso di mezzi inquinanti e favorire il trasporto alternativo, ma che è fondamentale ‘inserire il cervello’ e, quindi, adottare un approccio razionale, basato su dati concreti e non su ottuse ideologie. Purtroppo, in molte città il trasporto pubblico – inclusa la metropolitana – è deficitario e questo rappresenta un ostacolo significativo alla riduzione del traffico privato.
Un’altra questione riguarda l’autoprotezione dei cittadini: per quel che riguarda la prevenzione quali strumenti e strategie vengono consigliati per ridurre l’esposizione agli agenti inquinanti? Sarebbe utile diffondere informazioni pratiche su come gestire le abitudini di vita, sugli orari migliori per svolgere attività fisica all’aperto, portare a spasso i bambini, per arieggiare le abitazioni, sull’uso di purificatori d’aria per interni o di mascherine per chi si sposta in bicicletta. Un’app. che fornisca dati in tempo reale sulla qualità dell’aria in specifiche aree urbane potrebbe essere un valido supporto.
Monitoraggio e correzioni. Come in ogni terapia, è essenziale monitorare il decorso della malattia e modificare gli interventi in base ai risultati man mano ottenuti, tenendo conto dell’urgenza del problema e del rischio che gli effetti collaterali delle misure adottate possano essere più dannosi della patologia stessa.
È, quindi, fondamentale valutare il rapporto costi-benefici e misurare concretamente l’impatto dei provvedimenti adottati, cercando soluzioni efficaci attraverso un’analisi delle variazioni delle variabili indicative del fenomeno sotto osservazione e mettendole in relazione con gli interventi effettuati, sia a livello generale che specifico. È altresì essenziale evitare distorsioni interpretative, come il rischio di “bias”, ad esempio, nel caso dell’aumento della percentuale di utilizzo delle piste ciclabili: dire che il numero di ciclisti su una di esse è aumentato del 100% potrebbe sembrare un successo, ma se si passa da 10 a 20 ciclisti al giorno il risultato in termini di riduzione dell’inquinamento è trascurabile. Sarebbe, invece, più utile misurare la riduzione effettiva delle emissioni e del traffico automobilistico, piuttosto che limitarsi a indicatori parziali, e fare un bilancio includendo anche l’impatto derivante dagli ingorghi provocati dagli ostacoli alla viabilità.
Per monitorare l’efficacia delle misure anti-inquinamento sarebbe, poi, utile conoscere le variabili considerate, come le diverse componenti dell’inquinamento, in relazione alle aree e agli orari, la loro misurabilità, i tempi e la frequenza delle analisi e le eventuali strategie di correzione in caso di scarsa efficacia delle soluzioni adottate. Come accennato precedentemente è fondamentale che i provvedimenti non risultino controproducenti: alcuni ostacoli alla fluidità del traffico, secondo l’equazione sopra ipotizzata, possono addirittura aggravare il problema. Ad esempio, i limiti di velocità a 30 km/h, pur essendo validi per la sicurezza stradale, potrebbero avere effetti negativi in termini di inquinamento, poiché comportano un maggior numero di frenate e l’uso di marce basse, aumentando così il numero di giri del motore e, di conseguenza, le emissioni.
Un approccio su misura. Le procedure cliniche si basano su protocolli condivisi, aggiornati regolarmente sulla base delle nuove evidenze, ma devono essere adattate alle diverse situazioni di diversi gruppi di pazienti: dall’evidence-based medicine alla precision medicine. Anche il contrasto all’inquinamento dovrebbe seguire un modello simile, evitando di replicare in modo acritico strategie adottate in contesti urbani molto diversi. Per esempio, la ciclizzazione delle città olandesi ha dato ottimi risultati, ma in un contesto urbanistico come quello di Torino sarebbe di difficile applicazione. Più efficace potrebbe essere sfruttare meglio gli ampi viali a disposizione e rendere efficiente l’organizzazione semaforica (onda verde, temporizzazione dei semafori e sistema start-stop delle auto). E’ sicuramente nociva anche la presenza di barriere con pedaggio sulle tangenziali, che deviano e ingorgano il traffico in aree urbane nelle quali si può transitare senza dover pagare.
Sempre nell’ottica di un approccio su misura, ci si chiede anche perché nella quantificazione dell’inquinamento ci si basi esclusivamente sui picchi di sforamento anziché considerare anche l’area sottesa alla curva dei vari inquinanti, variabile che renderebbe più accurata la rappresentazione del fenomeno.
Conclusioni. Questi sono alcuni tra i quesiti clinici che un medico si può porre e, ribadisco, si tratta di domande e non di affermazioni. Per quanto riguarda il traffico è evidente che la riduzione del numero di auto in circolazione rappresenta un mezzo per contrastare l’inquinamento, ma non può essere considerata un fine a sé stante. Il problema principale riguarda le modalità con cui viene attuata: ostacolare il traffico anziché fluidificarlo a una velocità moderata potrebbe non portare a una reale diminuzione delle auto in circolazione, ma solo a un aumento dell’inquinamento, pur con un numero leggermente inferiore di veicoli sulle strade.
Esistono strategie alternative, come per esempio il blocco totale del traffico nel centro cittadino, che richiederebbe però enormi parcheggi di interscambio e un trasporto pubblico estremamente efficiente e capillare, condizioni molto difficili da realizzare in modo funzionale. Un’altra misura è la “città dei 15 minuti” – in cui i servizi essenziali sono raggiungibili a piedi in un quarto d’ora – che è già parzialmente presente nell’area torinese ma che non sembra, almeno a Torino, avere un impatto significativo sulla riduzione dell’inquinamento.
Il rischio è che interventi parziali si rivelino inefficaci o, addirittura, peggiorino ulteriormente la situazione posticipando la soluzione al problema, quando invece sarebbe urgente e necessario intervenire in modo più preciso e incisivo anche su altri fattori critici, come i già citati riscaldamenti/ condizionatori e il settore agro-zootecnico, aspetti spesso trascurati anche nel dibattito pubblico.
Lodovico Benso
Auxologo e Pediatra
Già Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Auxologia
Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.